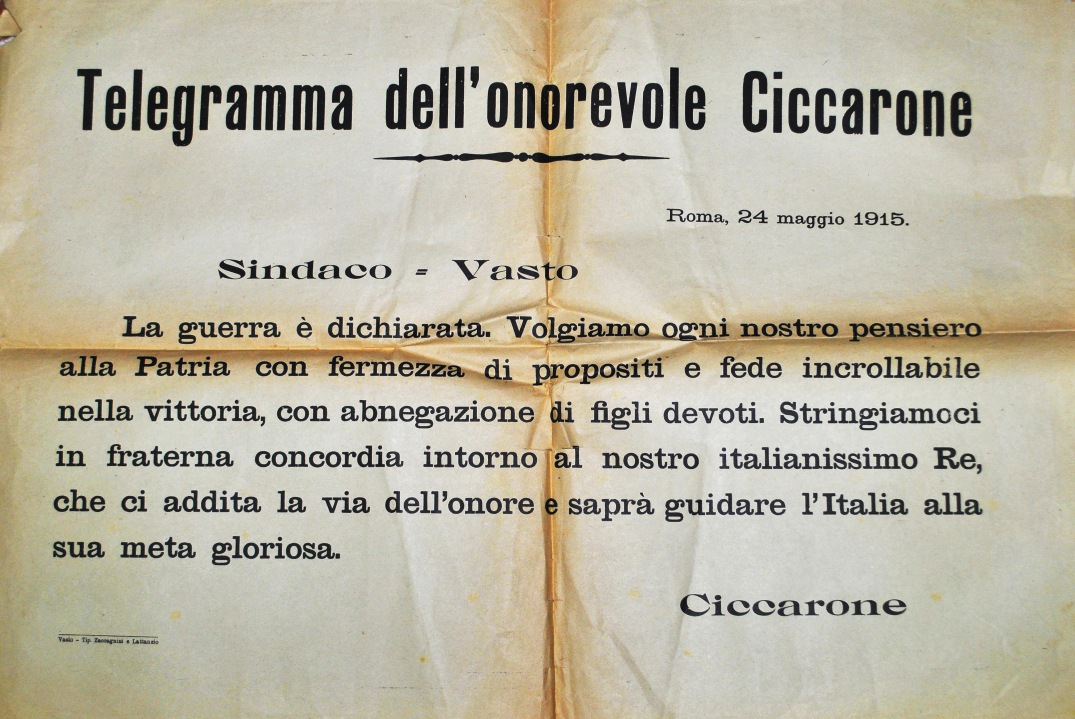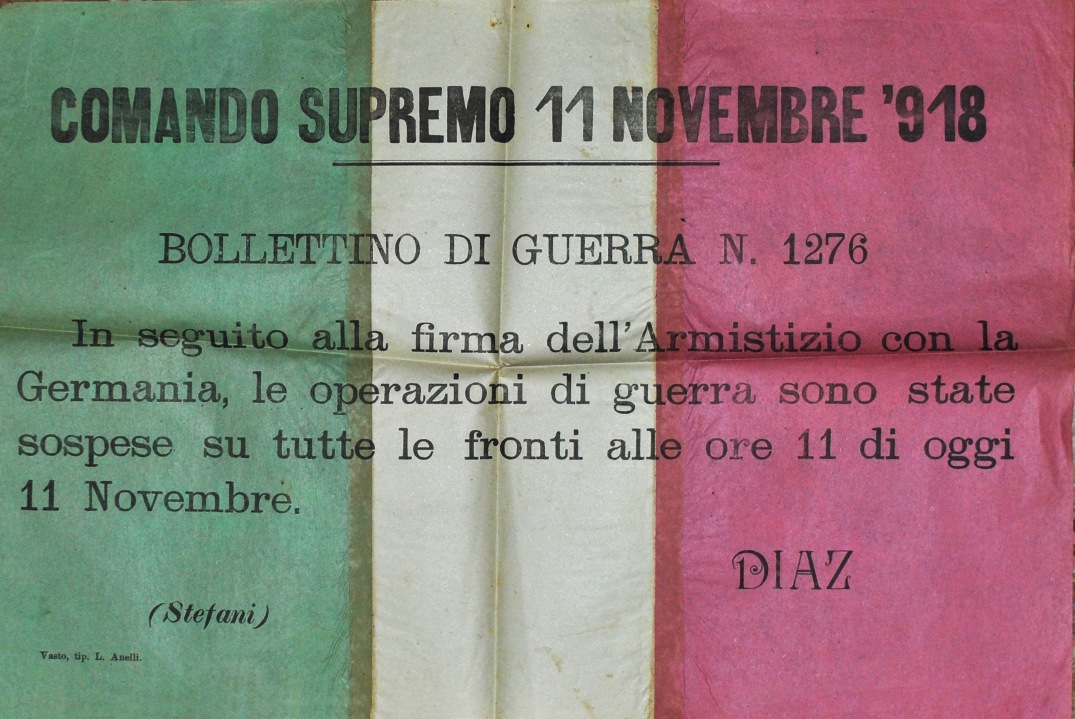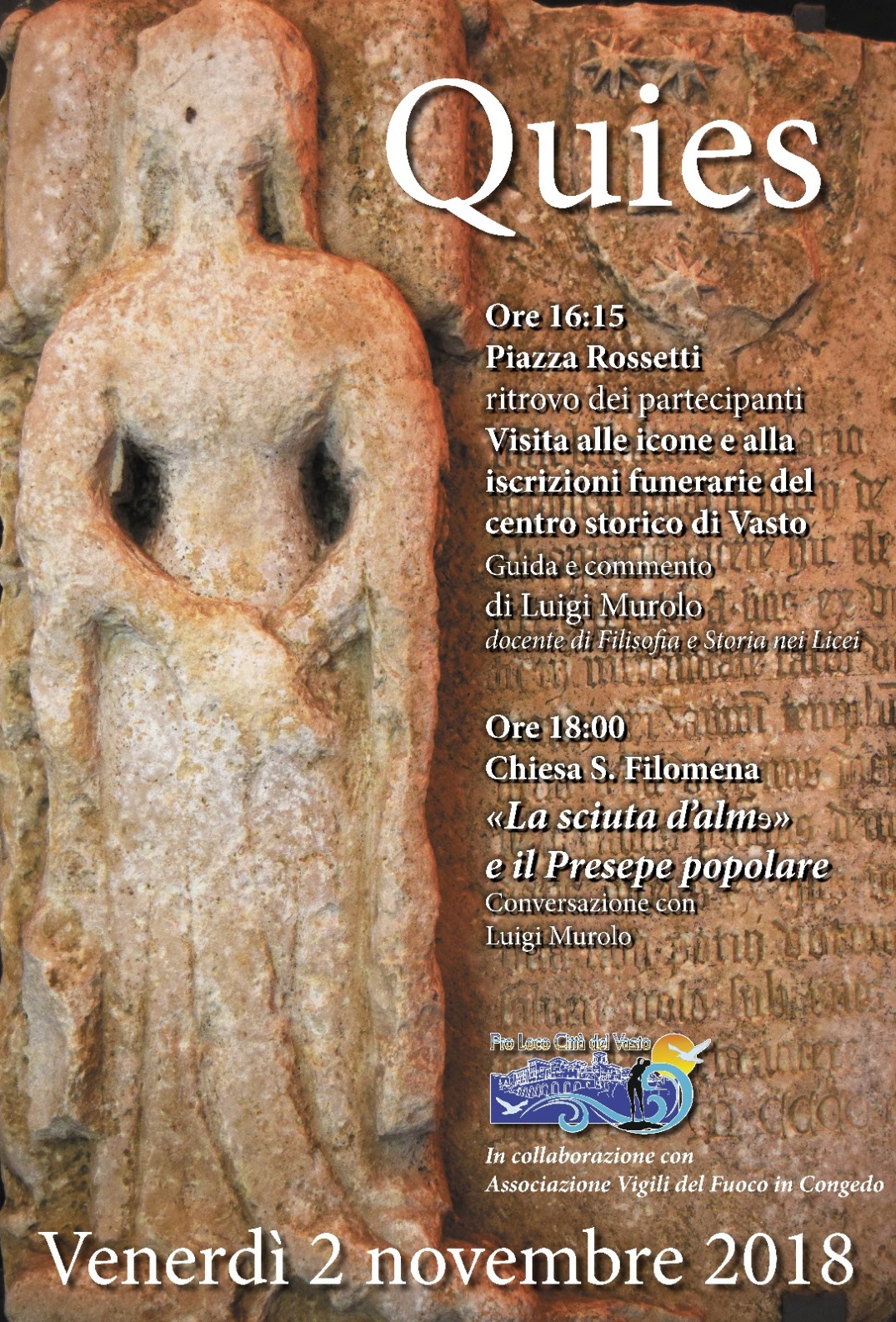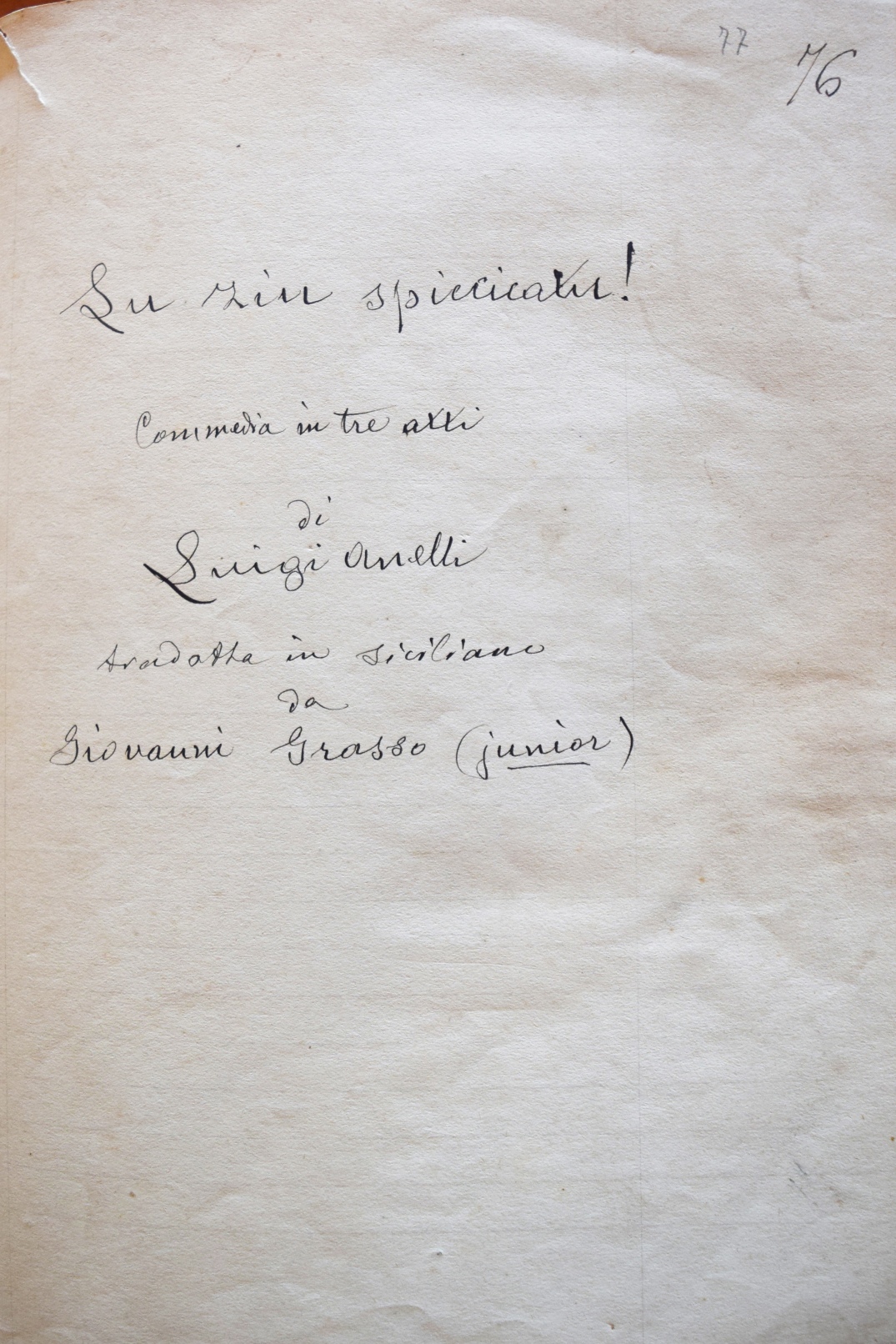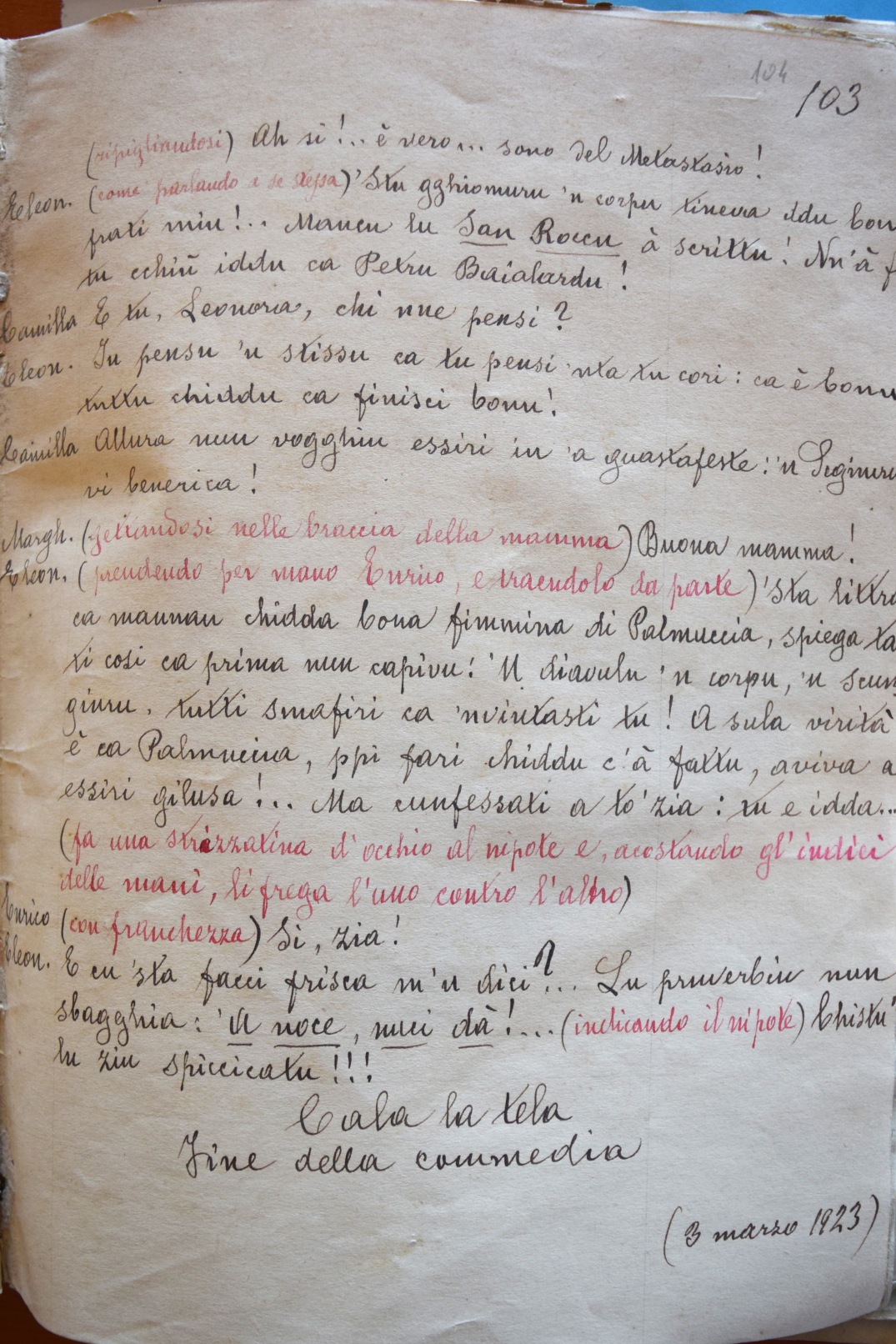di Luigi Murolo
Tutto ha inizio e fine in dicembre. Il 26 del 1194, la nascita; il 13 del 1250, la morte. Nel primo caso, in una tenda regale posta nell’antico Foro romano di una città nelle odierne Marche (significativo il disegno conservato nel manoscritto chigiano della Cronica di Giovanni Villani). Nel secondo caso, in un Palatium oggi non più esistente, nel sito di un allora importante centro strategico della Capitanata, anch’esso scomparso. Un «niente» visibile in superficie che, nel riemergere dal sottostante, modifica lo Sterparone (denominazione antica della contrada rurale in questione) in cui si era caratterizzato tornando alla natura, configurando la forma di «ex-sistere», di «star fuori» da ciò che, per centinaia di anni, era diventato un non-più.
Che dire! Di resti archeologici come quelli qui esibiti, il suolo italiano è ricchissimo. Quasi a suggellare una sorta di omologazione, di fatto solo apparente. Anzi, testimonianze di una radicalità di differenze, ognuna di esse segna l’unicità di un già-stato. Sicché, il modo del venire-alla-luce-del-singolo-già-stato (lo scavo), nel suo aprirsi allo scoperto, rende temporale – e, di conseguenza, storico – ciò che in precedenza era stato chiuso nel nascondimento della terra. Le relazionalità che si stabiliscono con l’ambiente e con l’osservatore vivono nell’esser-ci l’esistenza della «cosa». Di qui il fascino del genius loci. Di qui il passato che, diventando presente, declina il senso di possibilità in esso implicito.
Ernst H. Kantorowicz, uno dei grandi storici delle istituzioni medievali del Novecento, nella sua straordinaria ricerca sui due corpi del Re (tr. it. Torino, Einaudi, 1989), ha indagato i due aspetti che convivevano nella figura sovrana: da un lato, la persona ficta (cioè, persona fittizia; un’entità diversa dagli uomini, che si manifesta attraverso l’agire di uomini che la rappresentano); dall’altro, la dignitas – immateriale – che non muore mai – e che, con la sua auctoritas, conferisce l’effettiva legittimazione del potere.
Ora, da questo punto di vista, occorre ricordare che a Castel Fiorentino, il sito medievale abbandonato di cui abbiamo finora parlato (localizzato nell’attuale territorio di Torremaggiore), moriva Federico II, lo stupor mundi, dopo l’infezione contratta a Termoli nel giugno del 1250. Quasi non bastasse, con la scomparsa del Rex Romanorum, sarebbe venuto a scomparire in tempi successivi lo stesso luogo che aveva ospitato, fino all’ora del trapasso, l’agonizzante persona ficta. Con l’aggiunta che il corpo del Sovrano, una volta imbalsamato, sarebbe stato definitivamente traslato e allocato (25 gennaio 1251) in un’arca di porfido rosso, nella navata meridionale della Cattedrale di Palermo vicino alle spoglie del Rex Siciliae Ruggero II, suo nonno.
La singolarità e la suggestione del tema si trova proprio in questo: che la fine di Federico avvia la fine della stessa città in cui spira. E se ciò, per un verso, aveva alimentato la leggenda della terribile profezia vaticinata da Michele Scoto secondo cui lo Stupor mundi sarebbe morto in un paese il cui nome, al suo interno, conservava il termine «fiore» (motivo che, pare, aver tenuto il Monarca sempre lontano da Fiorenza); per l’altro, nessuno aveva previsto il contrario: e cioè il fatto che la morte di Federico avrebbe trascinato con sé la morte della città. Nessuno si era spinto fino a tanto. Nemmeno quel Michele Scoto di cui Dante avrebbe detto meraviglie: «Quell’altro che ne’ fianchi è così poco, / Michele Scotto fu, che veramente / de le magiche frode seppe ‘l gioco» (Inf., XX, vv. 115-117), e che lo stesso Boccaccio lo avrebbe ricordato come «gran maestro in nigromantia» (Decameron, VIII, 3).
Una cosa però è certa. Laddove sapienti, astrologhi, negromanti non giungevano a formulazioni predittive di tale natura, gli stessi avrebbero di certo potuto trovare indicazioni del medesimo tipo nella cultura popolare del tempo. Ancora nel XIX secolo sopravvivevano credenze che presupponevano il realizzarsi di esiti così nefasti. Ma sempre a condizioni date. Ad esempio, le ricerche etnologiche di Gennaro Finamore registrano testimonianze di questo genere. Raccolte perfino a Vasto. Nelle Tradizioni popolari abruzzesi (Torino-Palermo, Clausen, 1894, p.83), proprio per Il Vasto, Finamore scrive: «Se l’orologio batte quando la campana annunzia un’agonia, quande sóne la scìuta d’alme, morranno presto sette capi di casa». Va da sé che, in un contesto di tal fatta, per i negromanti del XIII secolo i «sette capi di casa» potevano essere tranquillamente rapportabili alla città e ai suoi abitanti.
Ora, di là dalle infinite divagazioni narrative sovrapponibili alla realtà storica, ciò che conta in questa sede è prospettare quali e quante sollecitazioni possa produrre una visita solitaria in un ambiente di scavi archeologici come l’antica collina di Sterparone, ritornata oggi Castel Fiorentino. La possibilità di un fluire di pensieri che sembra poter rinviare a quel passo di Heidegger che, nella sua abissale profondità, recita testualmente: «Il rapporto dell’uomo ai luoghi e, attraverso i luoghi, agli spazi, risiede nell’abitare. La relazione di uomo e spazio non è null’altro che l’abitare pensato nella sua essenza» (M. Heidegger, Saggi e discorsi, Milano, Mursia, 1985, p.105). E sempre per Heidegger «l’abitare è il modo in cui i mortali sono sulla terra» (op. cit., p.98). Magari no. Nulla di tutto questo! Il fascino, però, sì! Il fascino che si vive in questo genius loci quando le cognizioni di cui ognuno dispone sul Puer Apuliae, si affollano nella mente trasformando quel sito, agli occhi di ogni visitatore, in uno scrigno di «grande bellezza» (magari ascoltando dal web come accompagnamento musicale l’Under der linden di cui è autore quel Walther von der Vogelweide, massimo cantore del potere imperiale).
Un’ultima considerazione. Quando parlo di questi argomenti non posso non pensare all’epistula datata Anagni, 18 ottobre 1255 con cui papa Alessandro IV ricorda agli abitanti di Pennaluce la fondazione della città voluta dal fu Federico II (il documento è trasmesso dal Registro 24, c.102v, n.699 dell’Archivio Segreto Vaticano, pubblicato nel 1902. Lo stesso è stato utilizzato da Davide Aquilano per gli scavi condotti, e poi ricoperti, nella piana di Punta Penna nel 1993, e dal 1494 divenuta parte integrante del territorio del Vasto. Il testo è stato ripreso, controllato e interamente ripubblicato dallo stesso studioso in Insediamenti, popolazione e commercio nel contesto costiero e molisano [sec. XI-XIV]. Il caso di Pennaluce, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen âge. Tome 109 – 1997 – 1», pp.125-126). Mi chiedo: riesce qualcuno a pensare all’esistenza nascosta nel sottosuolo di una città federiciana? Che nell’area compresa tra la Cappella e la Torre Cavallara, tra il grande prato e le case popolari i resti custoditi dalla madre Terra raccontano l’abitare umano pensato e realizzato dalla volontà costruttrice dello Stupor mundi? Di questo non so dire. Mi piacerebbe però che una piccola stele lapidea, posta sulla sua superficie, recasse un’iscrizione del seguente tenore:
QUI
NEL NASCONDIMENTO DELLA TERRA
LE PIETRE DI PENNALUCE
VOLUTE DALLA MANO SOVRANA DI
FEDERICO II DI SVEVIA
ATTENDONO L’APERTO
Già! Di là dai deserti incontrati lungo questo percorso la Terra respira ancora, lasciando emergere dal suo humus una flebile voce che può essere intesa solo da chi ha scelto di porsi in posizione di ascolto per accogliere in sé la voce senza tempo delle «cose» insieme con la meraviglia che si prova nella contemplazione delle stesse. Qui c’è solo la parola struggente del Nietzsche di Ecce homo che può restituire in qualche modo il senso della presenza che si guarda, ma non si vede. Ecco perché di fronte all’opera scomparsa di Federico II mi sento di poter dire:
La mia anima, una corda
toccata dall’invisibile,
a sé cantava in segreto
una canzone […],
tremando di beatitudine multicolore.
-L’ha qualcuno mai udita?…